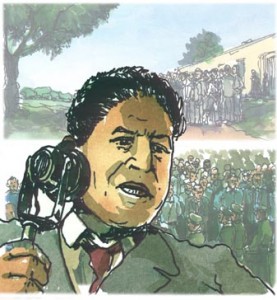
di Roberto Polidori
Il Sole 24 Ore fa lo scoop: in fondo Giuseppe Di Vittorio era liberista!!! Nessun quotidiano nazionale si è reso conto che Venerdì 27 Maggio 2011 è stata una data storica perchè ha sancito che il padre fondatore del sindacato CGIL aveva varato il Piano del Lavoro del Febbraio 1950 chiedendo ulteriori sacrifici ad operai e braccianti agricoli per permettere all’Italia il colpo di reni sul sentiero della crescita e del successo. Applausi convinti da parte di CISL, UIL e UGL. Sgomento tra i quadri direttivi CGIL: “Ma come? Ma allora, se persino Di Vittorio disse una cosa del genere, dobbiamo rassegnarci, rinunciare ai nostri residui diritti ed incamminarci fiduciosi sul sentiero delle liberalizzazioni e della flessibilità! Allora hanno ragione i numerosi “compagni di viaggio” che hanno stretto forti legami con i colleghi di CiSL e UIL !”.
IL 26 Maggio Confindustria ha tenuto la sua Assemblea Annuale di fronte alla platea di industriali e politici con una vistosa assenza, quella di Berlusconi, il cui programma – come invece giurò a D’Amato nell’Assemblea del 2001 – non è stato evidentemente quello degli iscritti alla potente associazione di industriali: questo imprenditore non ha liberalizzato quanto avrebbe dovuto – e meno male: l’Italia è ormai un paese senza industria primaria pubblica –, non ha deregolamentato quanto sarebbe stato necessario – nonostante il falso in bilancio sia legge ed ISTAT ed FMI quantifichino ormai l’evasione fiscale imponibile in Italia in 250 MLD di euro annuali -, non ha “flessibilizzato” quanto preconizzato per ridurre la disoccupazione – ed infatti in data 23 Maggio il Direttore dell’ISTAT Giovannini, alla presenza del Presidente Napolitano, ha detto nel Rapporto Annuale Istat 2010 che:” I giovani e le donne hanno pagato in misura più elevata la crisi, con prospettive sempre più incerte di rientro sul mercato del lavoro, le quali ampliano ulteriormente il divario tra le loro aspirazioni, testimoniate da un più alto livello di istruzione, e le opportunità. Una quota sempre più alta di giovani scivola, non solo nel Mezzogiorno, verso l’inattività prolungata, vissuta il più delle volte nella famiglia di origine, e verso bassi livelli di integrazione sociale, soprattutto per quelli appartenenti alle classi sociali meno agiate”.
Ma per la Marcegaglia i colpevoli di questo declino decennale del paese – il decennio “perso” – sono essenzialmente due: un governo non sufficientemente liberista ed un sindacato in particolare, la CGIL, che ha ostacolato il processo di incremento di flessibilità dei rapporti di lavoro. Due considerazioni prima di riproporre le parole di Di Vittorio citate dal giornale di Confindustria: la CGIL è il sindacato che firma il maggior numero di contratti in Italia; viviamo nel paese OCSE con il maggior numero di forme contrattuali di lavoro precario che hanno ridotto al lumicino le protezioni del lavoratore (indicatore OCSE 2009: Indice di Protezione del Lavoro).
E veniamo all’illuminante citazione: «….i lavoratori di fronte ad un’azione diretta a promuovere la rinascita economica e civile dell’Italia, pur trovandosi nelle condizioni che sappiamo, pur essendo essi i più sacrificati della società, sono giunti oggi nel nostro Paese ad un grado di maturità tale, ad un grado di sensibilità così elevata verso gli interessi generali della società nazionale, che questi lavoratori, pur soffrendo, sono disposti ad accollarsi un sacrificio supplementare per portare un proprio contributo al successo del piano lanciato dalla CGIL (applausi) ». Questo periodo, estrapolato dal discorso tenuto a Roma per presentare il Piano del Lavoro in occasione della Conferenza Economica Nazionale del Febbraio 1950, sarebbe la prova inconfutabile che, in altri momenti storici, anche il sindacato più duro ha avuto il coraggio di predicare moderazione salariale a chi già soffriva la fame del dopoguerra per il bene collettivo superiore…«E’ ciò che i lavoratori dovrebbero fare ora, perchè la moderazione salariale oggi ci farà crescere tutti, noi imprenditori oggi e voi lavoratori domani», sembra suggerire il trafiletto in prima pagina. Ed infatti, ci dice subito dopo l’autore del pezzo, l’Italia fece registrare un incremento del PIL pari al +260% dal 1945 al 1960. Evviva !!!
Colgo l’occasione per ribadire ancora una volta che la proposizione sic et simpliciter di un dato statistico vuol dire poco se il dato non è “letto” alla luce di altre grandezze che siano in grado fornire conferme circa il significato reale del dato stesso. Rilevo un problema di “metodo scientifico” nella quantificazione del dato numerico. Affermare che il PIL italiano crebbe del 260% dal 1945 al 1960 (al netto dell’inflazione registrata) non dice niente, ad esempio, circa il dato di partenza del Pil italiano nel 1945. Al termine della seconda guerra mondiale l’Italia, molto meno che la Germania e la Francia, aveva subito un discreto sfacelo a livello di dotazione infrastrutturale, che interessò marginalmente le imprese produttive perché l’Italia era un paese rurale: i tre settori industriali più importanti erano essenzialmente l’industria alimentare, il settore tessile e l’ediliza, mentre la siderurgia, l’industria dell’automobile e l’industria chimica dovevano ancora essere sviluppate (mentre Germania e Francia erano già avanti anni luce). La caratteristica essenziale del “periodo della ricostruzione italiana” fu proprio il passaggio da un’economia autarchica e chiusa ad un’economia aperta (chiamiamola “di mercato”); fu una scelta politica (voluta fermamente dalla ricca borghesia per controllare il forte partito comunista) e fu una scelta di politica economica: si voleva passare dall’economia controllata dell’esperimento fascista all’economia di mercato che continuasse a non intaccare le ricche rendite (non di mercato) delle classi privilegiate, minacciate dal pericolo rosso. L’ Italia doveva aprire le frontiere all’integrazione economica (in questo aiutata dagli States) proprio perché il nostro paese è piccolo e si è sempre caratterizzato per l’assenza di materie prime: una volta abbracciato il nuovo sistema economico, per esportare prodotti finiti era necessario abbandonare l’autarchia mussoliniana ed importare fattori produttivi e materie prime. Insomma, l’Italia partiva da zero, la guerra aveva contribuito ad affossare il paese e il nostro paese cambiava in quel frangente sistema economico. Effettuare l’analisi di una serie statistica prendendo come punto di partenza l’anno in cui un sistema economico viene stravolto ed una guerra finisce mi sembra un po’ fuorviante e scientificamente inammissibile; il 1945 fu per l’industria il nostro anno peggiore: in termini di disponibilità di prodotti per il consumo, il settore tessile registrò una disponibilità totale di 53.000 tonnellate prodotte rispetto le 225.000 tonnellate del 1940. I prodotti siderurgici calarono da 2,7 milioni di tonnellate del 1940 a 0,4 milioni di tonnellate; solo l’iniezione di 450 milioni di dollari di aiuti americani nel 1946 riuscirono a sollevare un po’ il PIL italiano (non grazie il lavoro di sagaci “nuovi” imprenditori). L’incremento del PIL del 260% in 15 anni equivale ad un aumento medio annua dell’economia italiana pari al 6,6%. Se volessi azzardare confronti poco coerenti come fa Confindustria potrei dire che il “miracolo cinese” – aumento medio annuo pari all’8,5% da almeno 10 anni – è quindi ben più importante del “miracolo italiano” del quindicennio magico. Fatte salve le chiare differenze dimensionali (e di dotazione di materie prime), anche la Cina usciva da un’economia pianificata (un’oligarchia comunista) basata soprattutto sull’agricoltura anche se governata da un latifondo statale ben diverso dal latifondo privato del Sud Italia.
E veniamo ora all’impropria elaborazione del pensiero di Di Vittorio ad uso e consumo di Confindustria. L’Italia uscita fuori dalla Seconda Guerra Mondiale era un paese povero caratterizzato da tassi di disoccupazione enormi e da indice di concentrazione delle ricchezze altrettanto grande (lo 0,50% della popolazione possedeva il 35% delle terre coltivabili); Vittorio Foà dirà : «La disoccupazione di massa è il vero grande protagonista della storia italiana del secondo dopoguerra»; il passaggio ad un sistema economico di mercato sancì la sconfitta del Partito Comunista e la conclusione di un accordo di governo in cui le forze di destra e di sinistra si fronteggiavano quasi con la stessa potenza di fuoco.
Un analogo compromesso a livello sindacale fu molto più complesso perché la forza delle sinistre nella CGIL del 1945 era prevalente; anche in CGIL esisteva un patto con i cattolici, che venne messo in difficoltà dalle pressioni delle masse operaie e contadine scontente. La CGIL, come ora, si trovava nel 1945 in grandissima difficoltà: l’inondazione di moneta battuta per finanziare la ricostruzione (grazie agli aiuti americani) aveva determinato un’inflazione galoppante nei confronti della quale l’area rivendicativa del sindacato – quella tesa ad ottenere miglioramenti salariali e delle condizioni di vita dei lavoratori – entrò in crisi quando accettò la linea del padronato, secondo cui i salari andavano limitati e i lavoratori andavano protetti con il controllo dell’andamento dei prezzi. La linea rivoluzionaria della CGIL, quella che metteva in discussione le fondamenta stesse dl sistema economico scelto, invece non divenne mai maggioranza. La CGIL si ritagliò uno spazio abbastanza angusto da quando il blocco ai licenziamenti fu abolito in cambio dell’introduzione della scala mobile; la storia ci dice che la disoccupazione aumentò in modo spaventoso in Italia perché, allora come ora, una volta eliminato il blocco dei licenziamenti – voluto nel 1945 dai rivoluzionari di sinistra e durato pochissimo – gli industriali si avvalsero pienamente della possibilità di assumere a cottimo (il precariato di oggi cos’altro è?), reintrodotto per rendere flessibile la forza lavoro. L’allontanamento delle sinistre dai governi di coalizione ad opera di De Gasperi nel 1947 diede un’ulteriore spallata alla CGIL: il nuovo governo democristiano puntò al contenimento della spesa pubblica (ricorda qualcosa?) liberalizzando la spesa privata, che veniva considerata produttiva. Risultato? Le nuove ricette liberiste convinsero De Gasperi a eliminare i vecchi prezzi politici del pane, il prezzo del pane aumentò enormemente (era il bene di consumo più richiesto della numerosa povera gente) causando ulteriore povertà in Italia, nonostante l’aumento reale del PIL (cioè della ricchezza reale). Ecco un altro esempio di redistribuzione.
Autorevoli economisti e storici dell’economia ritengono che l’inverosimile incremento del credito bancario fu volutamente perseguito da De Gasperi per determinare una situazione “inflazionistica” talmente fuori controllo da giustificare un intervento dello Stato atto a smorzare qualsiasi pretesa di incremento salariale della CGIL. Gli storici Barbagallo ed Ascoli ci consegnano un’impressionante serie storica di dati relativi alle emigrazioni nette in Italia nel periodo 1946-1966, provenienti in gran parte dal Sud: mediamente dai 100.000 a 200.000 espatri annui per un ventennio; questa è la storia. La moderazione salariale è stata anche attuata con l’endemica emigrazione italica, soprattutto in pieno miracolo economico.
Il Piano del Lavoro di Di Vittorio era un piano neo-keynesiano di intervento pubblico nell’economia e prevedeva un fortissimo impegno di risorse statali: non credo proprio che Giovedì 26 Confindustria abbia voluto ricordare questo particolare; nell’Italia del Piano del Lavoro i disoccupati erano 2 milioni e come spiegò Di Vittorio, il piano tendeva «a utilizzare la forza lavoro disponibile e le possibilità potenziali di sviluppo della produzione, nella misura in cui sono utilizzabili in un regime capitalista». Di Vittorio e la CGIL erano, come ho spiegato, in un angolo angusto e, in un contesto segnato da una forte disoccupazione, retribuzioni misere e una generale debolezza delle infrastrutture, l’idea era di porre mano a un programma nazionale di opere pubbliche, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni fondiarie, potenziamento della produzione energetica (accompagnato dalla nazionalizzazione – avete capito bene: nazionalizzazione – delle industrie elettriche).
Disse Foà di questo piano: «Era difficile cioè fare approdare il movimento ad una strategia capace di unificare i diversi fronti di lotta intorno ad un disegno consapevole e complessivo di alternativa positiva, di riconversione dell’assetto produttivo, con gli elementi di riforma e gli strumenti di potere capaci di garantirne la realizzazione. Si apriva così, per questa via, un “divorzio drammatico” fra esperienze di fabbrica e lotte generali per il lavoro e il salario. Si creava, detto in altro modo, una separazione netta tra occupati e non». Separazione che invece proprio nelle intenzioni del Piano era rigorosamente esclusa. Ma il fatto “è che l’ancora altissima capacità di mobilitazione della Cgil non era a quell’epoca al servizio di una linea che fosse correlata a una strategia salariale coerente. Perciò, più per urgenza di problemi che per propensioni originarie, la priorità politica andava alla battaglia contro la disoccupazione endemica e congiunturale, anche se era chiaro a molti che le lotte soltanto per l’occupazione, con o senza sacrifici – la moderazione salariale dei lavoratori –, non incidono sul meccanismo di sviluppo e non mobilitano neppure tutta la classe operaia». Il piano era una proposta alternativa alle grandi concentrazioni industriali che poggiava troppo poco sulle battaglie. Il piano si pose obiettivi che nessuno da nessun’altra parte perseguiva: di sviluppo produttivo, di aumento della produttività, di riconversione industriale, di riassetto culturale dell’agricoltura, di modifica delle condizioni di lavoro. Il giornale di Confindustria ricopia un breve estratto della presentazione del Piano senza dirci che trattava di un riposizionamento verso il basso che mirava al recupero di tutta la classe dei lavoratori, occupati e non; né dice che il piano prevedeva il rilancio dei consigli di gestione, dei comitati comunali per l’occupazione, dei comitati per la terra, dei comitati cittadini per la difesa dell’occupazione e la riconversione industriale; non dice che il Piano era l’occasione per la formazione di un nuovo gruppo dirigente per la stessa Cgil; non accenna neanche alle caratteristiche con cui il “miracolo economico” si produsse ne decennio successivo: incentivato certamente dal controllo salariale, fu però motivato dalla favorevolissima congiuntura internazionale, dal divario crescente tra industrializzazione diffusa del Nord e impoverimento del Mezzogiorno, dal divario ancora più grande tra il salario dei lavoratori protetti delle poche grandi industrie e il salario dei lavoratori a cottimo delle numerosissime piccole industrie. Il datore di lavoro che non riesce ad aver successo grazie alle proprie capacità ma che ha il capitale in mano usa un’altra leva per guadagnare: seminare zizzania tra i lavoratori e acuire le differenze tra loro.
